Conoscere bene una lingua è interessante anche perché porta a sviluppare ragionamenti partendo dall’analisi del significato dei termini. Mi sono soffermato un attimo a pensare a noia e pigrizia, partendo dal chiarirne la differenza a livello di significato.
Partiamo da una sintesi, sicuramente non esaustiva ma utile.
La noia è quella del bambino da solo, che non riceve stimoli dal mondo esterno e che si inventa un mondo in cui giocare, che deve attingere a risorse interne, svilupparle, sperimentarle.
La pigrizia è quella del bimbo davanti ad un device, dove anche se cerca contenuti scrollando in realtà è guidato anche in quello da un algoritmo. Il bimbo che guarda uno smartphone, un tablet o anche la televisione non sta sperimentando le proprie risorse interne, è passivo. Per pigrizia si intende la mancata determinazione nel fare qualcosa.
Ovviamente, nessuna delle due deve essere demonizzata, noia e pigrizia non hanno una sola sfumatura. Bisogna anzitutto conoscerle e capire come gestirle.
Va da sé che la noia è una risorsa, che sperimentare noia, ovvero dover attingere internamente per potersi stimolare, è uno strumento di sviluppo. E’ un’opportunità, sperimentare la noia ci permette di capire quali sono le nostre risorse. E per poter avere risorse è giusto accumulare strumenti. Provare noia senza avere le risorse per riempirla potrebbe essere frustrante. Così come il bambino attinge alla propria fantasia per poter fronteggiare un momento di noia, così anche noi dovremmo essere dotati di strumenti cognitivi per sfruttare al meglio la noia.
Ma quando può esserci utile la noia, professionalmente? Ad esempio in un processo creativo, in un momento di problem solving. Riuscire ad indurci o ad avvicinarci ad una condizione di noia è importante per poter liberare le nostre risorse creative, per dar loro la possibilità di emergere. Dare al nostro cervello la possibilità di esprimersi senza condizionamenti o confini è sicuramente un approccio interessante.
E la pigrizia? La pigrizia è uno dei peccati capitali della Chiesa Cattolica, ha risvolti anche in mabito giuridico. Insomma, la pigrizia si porta dietro un’accezione esclusivamente negativa. Vero, non sono qui per un’operazione di rivalutazione della pigrizia, però il peso di certe credenze e definizioni deve essere commisurato al momento storico. In epoche in cui il ritmo di vita era molto blando, in cui l’alternanza giorno notte guidava la totalità delle faccende umane, essere pigro era un crimine. Non essere attivi e motivati nelle ore in cui c’era operatività significava perdere tempo prezioso. Ma oggi, ha ancora senso tutto questo accanimento verso la pigrizia? In parte sì, immagino. Il vero problema della pigrizia è che si sposa perfettamente con la condizione naturale del nostro cervello e quindi tende ad essere una condizione da cui si esce con fatica. Il nostro cervello deve processare in ogni istante una immensa quantità di informazioni. E’ necessario che sia pigro ed abitudinario, che reiteri comportamenti che si sono rivelati corretti e che abbia come focus il risparmo di energie. Quindi decidere di essere pigri asseconda il cervello e rende difficile poi riattivarsi. Però, dare una tregua al nostro corpo e alla nostra mente, portarla saltuariamente fuori ritmo è una condizione che non dobbiamo sottovalutare. La nostra società ormai è asincrona rispetto al ritmo dei giorni, non siamo guidati dal giorno e la notte, viviamo intensamente ogni minuto senza rallentare. Per questo, aggiornata ad oggi, la pigrizia può essere un momento da considerare. Certo, è rischiosa, è la tendenza naturale del nostro cervello ma possiamo correre il rischio.
Se questo contenuto ti ha incuriosito e vuoi approfondirlo, contattami alla mail nbertaccini@gmail.com


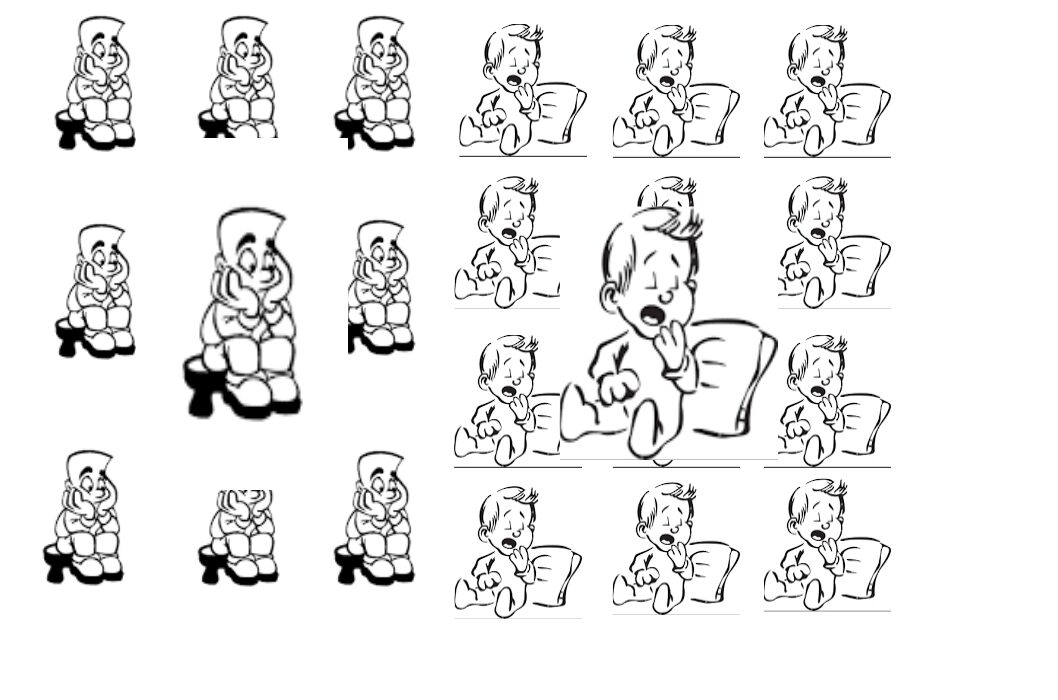

Lascia un commento